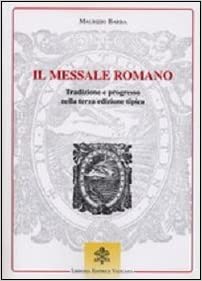 di Francesco Vermigli · È già tra le mani delle comunità la nuova traduzione italiana del Messale Romano. Si tratta della terza traduzione dai tempi della riforma conciliare: un’attesa durata anni. Com’è noto, l’edizione latina cui si riferisce la presente versione italiana, è la terza editio typica del 2002; fatte salve le piccole variazioni dell’editio typica emendata del 2008.
di Francesco Vermigli · È già tra le mani delle comunità la nuova traduzione italiana del Messale Romano. Si tratta della terza traduzione dai tempi della riforma conciliare: un’attesa durata anni. Com’è noto, l’edizione latina cui si riferisce la presente versione italiana, è la terza editio typica del 2002; fatte salve le piccole variazioni dell’editio typica emendata del 2008.
Si tratta di un libro liturgico ben confezionato, ad un primo sguardo. Nella grafica appare piuttosto tradizionale; alludendo a forme e stili grafici precedenti e non lasciandosi andare, per così dire, all’adattamento “modernistico” del libro liturgico. D’altra parte le immagini che inanellano il messale in italiano sono di un autore a noi contemporaneo, Mimmo Paladino; ma la loro sobrietà e schiettezza ed iconicità non paiono estranee all’impressione che questo libro liturgico intende trasmettere.
Tale brevissima presentazione dell’aspetto esteriore della nuova edizione italiana del Messale Romano serve a trattare più direttamente delle strategie di traduzione utilizzate. In effetti, questa compresenza di elementi nuovi e antichi, di forme antiche che accolgono espressività moderne, ben rappresenta proprio lo stile di traduzione che si rintraccia in questa nuova opera. Vi si avverte la preoccupazione di non appiattire la variatio dell’originale latino a causa di una traduzione sciatta. D’altra parte proprio questa preoccupazione rende conto di come il linguaggio liturgico – per quanto adattabile a sensibilità nuove – mantenga una propria identità inalienabile, fatta di stilemi e lessico che permangono nel corso del tempo.
Questi spunti a partire dalla traduzione in questione aprono a considerazioni più ampie, che si riferiscono all’atto stesso del tradurre; e all’atto del tradurre nella liturgia in modo specifico. La maggior parte del presente articolo è dedicata a questo.
Un antico adagio – che in italiano facilmente fa leva sull’assonanza – recita che “tradurre è tradire”: vale a dire che trasportare un testo da una lingua ad un’altra significa forzarlo, snaturarlo… fin quasi a farlo morire. In effetti, nelle originarie parole latine su cui si costruisce questo adagio italiano, non solo si nota l’assonanza tra traducere e tradere, ma in qualche modo anche una verità più profonda; dal momento che trans-ducere – cioè condurre un testo da una lingua ad un’altra – è un po’ come tradere, cioè consegnare quel testo alla lingua di arrivo: consegnarlo cioè a sintassi e lessico talvolta assai diversi rispetto alla lingua di partenza.
Non ci riferiamo qui agli errori. Si ricordi, solo per restare all’ambito ecclesiale, il celeberrimo errore in cui incorse il grande Girolamo quando scrisse che Mosè scese dal Sinai non con il volto raggiante, ma con il “volto cornuto”; leggendo male la radice triconsonantica ebraica krn. Oppure, si pensi ad alcune traduzioni italiane raccogliticce della Dei Verbum, che intendono le parole nostrae salutis causa a DV 11 come apposizione di Deus e non come complemento di fine, com’è giusto. Qui ci riferiamo alla resistenza che ogni lingua fa, quando riceve da un’altra lingua un testo.
Dunque, sembrerebbe che l’adagio dica il vero e che non si possa uscire da una dinamica fatta di forzature e piccoli o grandi tradimenti del testo di partenza. Oppure no; oppure questo non accade sempre. E su questo “oppure no” vogliamo dire qualcosa, prima di chiudere.
Vi è anche un’altra possibilità che appartiene all’atto del tradurre. Ed è, a ben vedere, l’esatto opposto del tradimento del testo della lingua di partenza. Non ci riferiamo tanto a quello che in linguistica va sotto il nome di “forestierismi”, che nell’apparente fedeltà alla lingua originaria sono in realtà una dichiarazione di fallimento nell’opera di traduzione. Ci riferiamo a qualcosa di diverso, anzi radicalmente diverso.
Si tratta cioè di quell’opera delicatissima e mai completa che consiste nella appassionata e competente ricerca di una traduzione capace, addirittura, di meglio far comprendere il testo di origine. Qui la traduzione acquista i tratti dell’ermeneutica, è un’opera interpretativa che svela il nascosto sotto la schiettezza della mera parola. Ha un compito interpretativo e rivelativo. Qui la traduzione è un’arte, un’arte che poi nel caso della liturgia e della vita della Chiesa si riveste di una componente teologica decisiva.
Se intendiamo così l’atto del tradurre, allora tradurre nella liturgia e nella Chiesa significa contribuire all’approfondimento dell’autocoscienza che la Chiesa ha di se stessa. Tradurre è svelare verità nascoste, che mediante quest’arte emergono alla coscienza della comunità dei credenti. Per questo la traduzione liturgica non potrà mai essere solo un settore della linguistica, ma parte integrante della teologia.
In questo caso, tradurre significa allora trasmettere, piuttosto che tradire. Trasmettere e affidare alle varie culture e alle varie lingue il contenuto della fede, in modo tale che di tutto quello che si crede e che si prega cresca la comprensione.

