Paternità e figliolanza nel romanzo «La strada» di Cormac McCarthy
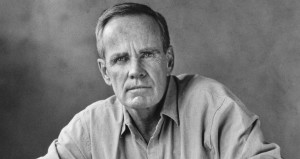 di Gianni Cioli • «Nel giro di due giorni arrivarono alla foce di un ampio fiume dove il ponte era crollato e giaceva in frantumi tra le acque lente. Si sedettero sulla spalla amputata che un tempo sosteneva la strada e guardarono il fiume rifluire, spinto dalla marea, e ingorgarsi attorno alle travature di ferro. E adesso che facciamo, papà?, disse l’uomo. Appunto, dimmelo tu, disse il bambino» (p. 209).
di Gianni Cioli • «Nel giro di due giorni arrivarono alla foce di un ampio fiume dove il ponte era crollato e giaceva in frantumi tra le acque lente. Si sedettero sulla spalla amputata che un tempo sosteneva la strada e guardarono il fiume rifluire, spinto dalla marea, e ingorgarsi attorno alle travature di ferro. E adesso che facciamo, papà?, disse l’uomo. Appunto, dimmelo tu, disse il bambino» (p. 209).
In questo stralunato scambio di battute fra padre e figlio, che prelude all’epilogo de La strada, possiamo rinvenire una delle possibili chiavi interpretative del romanzo di McCarthy. Il padre intende semplicemente prevenire affettuosamente la domanda che si aspetta dal figlio, o i ruoli si sono invertiti? Come se il padre avvertisse che è il figlio ad avergli dato la vita, e che lo sta educando perché possa portarla a compimento. Non a caso, il libro, forse per certi versi autobiografico, è dedicato all’ultimogenito dello scrittore.
La strada può dunque essere letto come un romanzo sulla paternità e la figliolanza, la responsabilità e l’affetto. Una storia di grande tenerezza, esaltata dal contrasto con l’ambiente ostile, raccapricciante, teatro di episodi crudi, di estrema spietatezza.
Classe 1937, Cormac McCarthy è autore di numerosi romanzi di successo: un titolo fra tutti, Non è un paese per vecchi (No country for old men) del 2005, da cui è stato tratto il fortunato film dei fratelli Cohen. La strada (The road), pubblicato l’anno successivo e vincitore del premio Pulitzer 2007, si distingue dai romanzi precedenti, ambientati generalmente in un passato più o meno recente, per la collocazione in un futuro prossimo all’indomani di un’imprecisata catastrofe.
Il disastro – forse una guerra nucleare – che ha ridotto in cenere il paese, pare avere scatenato in molti dei sopravvissuti le tendenze più disumane: sopravvivere diventa un’impresa estremamente ardua, non soltanto per l’ambiente ostile e per la mancanza di ogni genere di prima necessità, ma soprattutto per la presenza degli esseri umani. Un uomo e il figlio di pochi anni cercano di raggiungere la costa del sud di quelli che furono gli Stati Uniti d’America, nella speranza di trovare sulle rive del mare un qualche tepore e un barlume di vita. Possiedono soltanto quello che trovano, scampato al disastro e alle razzie. Custodiscono e trasportano i loro “beni” in un carrello del supermercato, paradossale contrappasso di uno dei simboli più usuali del consumismo, e apparentamento con la situazione di tanti homeless, il cui carrello della spesa pieno di oggetti recuperati nella spazzatura è a un tempo lo “status simbol” della loro marginalità e il compendio di una vita che attraversa il disastro, esposta com’è alla realtà quotidiana dell’irrilevanza sociale.
La narrazione procede serrata, scandita da una prosa scarna, fatta di descrizioni essenziali e dialoghi semplici, carichi di idealismo e di amore, come vorrebbero essere i discorsi fra un padre e il figlio. La presenza incombente della morte, continuamente in agguato e più volte sfiorata, per la penuria del cibo, rinvenuto poi miracolosamente, o per gli incontri con individui crudeli o con bande spietate e dedite al cannibalismo, rende il racconto carico di tensione.
Descrizioni e ricordi di sogni – spesso terrificanti, talvolta dolci – s’intrecciano alle descrizioni di una realtà raccapricciante – paesaggi spettrali disseminati di cadaveri essiccati – eppure ancora in grado di offrire squarci di bellezza – una cascata – e di suscitare lo stupore e l’amore per l’esistenza. Nella natura, all’apparenza del tutto morta, si intravedono timidi ma reali segni di vita, come le spugnole, funghi buoni da mangiare, nate in mezzo alla cenere.
Sfoghi di blasfema indignazione per le sofferenze apocalittiche si alternano a slanci di autentica religiosità.
I due protagonisti sembrano consapevoli di una missione da compiere: «portiamo il fuoco» (p. 64 cf. la conclusione di Non è un paese per vecchi). Un fuoco che è metafora dell’amore che i due sono ancora capaci di dare e ricevere, della capacità di volere il bene dell’altro e di volere il proprio bene per l’altro. Ma «il fuoco» sono anche i valori, i principi assoluti e le norme inviolabili che il bambino ha ricevuto ed elaborato – «Devi portare il fuoco … È dentro di te. Da sempre. Io lo vedo» (pp. 211-212) – e che difende a ogni costo come condizione imprescindibile per rimanere umani:
«Noi non mangeremo mai nessuno vero?
No. Certo che no.
Neanche se stessimo morendo di fame?
Stiamo già morendo di fame» (p. 98).
Ma che senso ha portare il fuoco se non c’è qualcuno capace di accoglierlo e condividerlo? Così la strada è anche e soprattutto un percorso di speranza, è desiderio di trovare dei simili che portino anch’essi il fuoco, dei “buoni” – per usare il linguaggio del bambino – in un mondo che pare ormai abitato e percorso solo da “cattivi”, nella speranza che l’umanità possa sopravvivere a se stessa e avere un futuro. L’incontro con l’altro è così costantemente temuto e desiderato. Gli altri sono di fatto l’inferno – per dirla con Sartre –, ma c’è un’attesa costante che, alla fine, si rivelino come paradiso, nonostante tutto. Una speranza che travalica nella dimensione religiosa. È significativo il dialogo che figlio e padre imbastiscono subito dopo aver sparato un segnale da una pistola lanciarazzi, trovata per caso in un relitto:
«Da molto lontano non lo vedrebbero, vero, papà?
Chi?
Chiunque.
No. Da molto lontano no.
Se volessimo far capire a qualcuno dove siamo.
Ai buoni intendi?
Sì. O qualcuno a cui vogliamo dire che siamo qui.
Tipo chi?
Non lo so.
Tipo Dio?
Sì, per esempio una cosa così» (p. 187).
Se il padre, nel rapporto col figlio, è figura di primo piano, anche la madre è presente, o quanto meno costantemente evocata. L’uomo la ricorda più volte, anche in sogno. La donna che si era tolta la vita nel “ragionevole” intento di sottrarsi alle atrocità prevedibili, “pietà” stoica in cui avrebbe voluto che anche il marito e il figlio la seguissero:
«Prima o poi ci prenderanno e ci ammazzeranno. Mi stupreranno. Stupreranno anche lui. Ci stupreranno, ci ammazzeranno e ci mangeranno e tu non vuoi affrontare questa verità. Preferisci aspettare che succeda. Ma io non posso» (p. 44).
La nostalgia della madre è forse implicita anche dal cammino verso il mare, l’oceano a sud, che tuttavia si rivela, una volta raggiunto, un grembo sterile, privo di vita, freddo, non già blu, ma plumbeo. Anche le donne, incontrate al seguito delle bande di devastatori, sono quasi sempre incinte: ma il loro compito non è quello di dare alla luce una posterità, bensì carne fresca di cui cibarsi. Soltanto nell’epilogo la figura della madre verrà rinvenuta e riscattata.
La strada, che non può non evocare altri titoli della letteratura americana – On the road – è forse anche un’allegoria o una serie di allegorie sull’America, le sue paure e i suoi ideali, i suoi miti, il suo manicheismo latente – “buoni” e “cattivi” –, la sua violenza, le sue guerre.
Il dialogo che segue quest’ultimo episodio è forse uno dei punti più alti della narrazione: il padre palesa la sua umanità riconoscendo la propria debolezza. Il bisogno di compromesso nasce, appunto, dalla presa d’atto della propria finitezza: riconoscersi nei limiti umani senza abdicare alla propria umanità. Al figlio che sta protestando e lo rimprovera, l’uomo ha il coraggio di confessare, come un bambino, la propria paura. Tra l’altro, si manifesta già qui chiaramente il ribaltamento dei ruoli che abbiamo rilevato all’inizio:
«Che cosa voi fare?
Aiutarlo papà. Voglio solo aiutarlo.
L’uomo si voltò a guardare la strada.
Papà, aveva solo fame. Adesso morirà.
Sarebbe morto comunque.
Ha tanta paura, papà.
L’uomo si accovacciò e guardò il bambino. Anche io ho paura, disse. Lo capisci? Anche io ho paura» (p. 197).