
di Gianni Cioli – Da buon discepolo di Tommaso, dotato comunque di una struttura di pensiero originale, Antonino Pierozzi, frate domenicano e vescovo di Firenze dal 1446 al 1459, nella sua opera teologica principale, la Summa Theologiae scritta in latino fra il 1440 e il 1459, delinea una triplice modalità della beatitudine o felicità: quella falsa e ingannevole, quella imperfetta e dispositiva e, infine, quella perfetta e oggettiva (Pars. IV, tit. 7, cap. 4, § 1).
La felicità falsa è data dall’inganno delle ricchezze, degli onori mondani, del potere, del piacere, del salutismo, della conoscenza originata dalla curiosità (Pars. IV, tit. 7, cap. 4).
La felicità dispositiva consiste nell’operazione virtuosa che procede dal dono dello Spirito Santo (Pars. IV, tit. 7, cap. 5). Essa trova la sua espressione paradigmatica, seppur paradossale, nelle beatitudini evangeliche (Pars. IV, tit. 7, cap. 6; cf. Mt 5). È esperienza autentica, sebbene imperfetta, della felicità. Lo è in quanto esperienza incoativa del sommo bene, vissuta attraverso la corretta misura nel godimento dei beni di questo mondo, e in quanto maturazione dispositiva al raggiungimento del fine ultimo, attraverso l’azione e la contemplazione esercitate nell’orizzonte delle virtù teologali che informano e orientano le altre virtù.
La felicità perfetta è il fine ultimo dell’uomo. Essa, in primo luogo, è Dio stesso, bene increato, beatitudine oggettiva e causativa, il solo che con la sua bontà infinita può appagare la volontà dell’uomo. In secondo luogo, essa è il raggiungimento o il godimento del fine ultimo, beatitudine adeptiva vel fruitiva. «La beatitudine, dunque, quanto all’oggetto e alla causa è qualcosa di increato, quanto invece alla sua essenza è qualcosa di creato». (Pars. IV, tit. 7, cap. 7, § 1).
Nell’Opera a ben vivere, un piccolo trattato spirituale scritto in volgare, composto tra il 1450 e il 1454 in risposta alle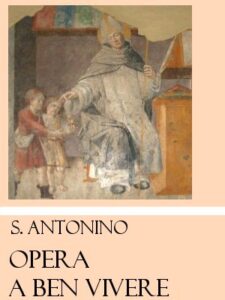 richieste di Dianora Tornabuoni, zia di Lorenzo il Magnifico, Antonino non utilizza, in verità, la parola felicità, né la parola beatitudine, sebbene offra spazio all’aggettivo beato, nelle varie declinazioni, e al verbo beatificare. L’esperienza della felicità imperfetta e dispositiva mi pare tuttavia il focus, per così dire, dell’Opera, finalizzata a guidare la zelante Dianora a un «qualche calore e gusto di Dio», come risulta chiaramente dalle prime parole del prologo:
richieste di Dianora Tornabuoni, zia di Lorenzo il Magnifico, Antonino non utilizza, in verità, la parola felicità, né la parola beatitudine, sebbene offra spazio all’aggettivo beato, nelle varie declinazioni, e al verbo beatificare. L’esperienza della felicità imperfetta e dispositiva mi pare tuttavia il focus, per così dire, dell’Opera, finalizzata a guidare la zelante Dianora a un «qualche calore e gusto di Dio», come risulta chiaramente dalle prime parole del prologo:
«Ricordandomi, diletta in Cristo, con quanta affezione e devozione la carità vostra m’ha pregato, ch’io vi debba scrivere, e ordinarvi qualche modo di vivere spiritualmente; il quale seguitando voi, potessi per mezzo d’esso pervenire a qualche calore e gusto di Dio» (Opera a ben vivere di santo Antonino arcivescovo di Firenze messa ora a luce con altri suoi ammaestramenti e una giunta di antiche orazioni toscane da Francesco Palermo, Firenze 1858, p. 3).
Si può ipotizzare che l’espressione «calore e gusto di Dio» fosse già nella richiesta di Dianora Tornabuoni, e che il vescovo Antonino l’abbia accolta e valorizzata nella sua opera. Ma il concetto di «gusto spirituale», collegabile al dono della Sapienza, è in realtà già significativamente presente nella Summa che cita, tra l’altro, a più riprese il Sal. 33,9: «Gustate e vedete quanto è buono il Signore», come quando, a proposito appunto della Sapienza, fa riferimento all’opera di Ugo di San Vittore (Pars IV, tit. 10, cap. 3, § 5).
«Calore e gusto di Dio» è, peraltro, un’espressione che ben si presta a focalizzare due traguardi del cammino spirituale, strettamente connessi: quello di giungere a un autentico fervore d’amore nei confronti di Dio, un calore appunto; e quello di provare perciò un gusto, ovvero un’esperienza di conoscenza e discernimento, un sapore, che si risolve in autentico gaudio, in dolcezza dilettevole, e dispone verso la piena beatitudine futura.
Il «gusto di Dio», ovvero la concreta possibile esperienza della felicità imperfetta e dispositiva, appare effetto e causa, in una circolarità virtuosa, del ben vivere, a cui il vescovo fiorentino, nell’Opera, vuole programmaticamente introdurre.
Il vero filo conduttore, ma potremmo anche dire il vero motore, di tutto il percorso di crescita nella felicità autentica è costituito dall’amore di Dio: «ingegniamoci», afferma Antonino, «di sempre e ad ogni ora avere in memoria li beneficii di Dio, per li quali ci possiamo innamorare e infiammare di Lui. E per lo innamoramento si viene a lasciare il male; e astenendosi l’uomo dal male, sì cresce lo amore e la buona volontà, e comincia a far bene: lo quale facendo con purità e simplicità di cuore, senza nulla duplicità, sì perviene al terzo grado, di possedere la pace della mente; nella quale perseverando, sì perviene a una sicurtà di sé, con dolcezza di Dio, che tutta si trasforma in Lui» (Opera a ben vivere, pp. 89-90).
L’abbrivio per articolare le fasi dell’impegno a vivere bene Antonino lo trova, infatti, nelle parole del Salmo 33 (che, detto per inciso, è lo stesso che invita a gustare quanto è buono il Signore): «Declina a malo, et fac bonum, inquire pacem, et persequere eam (Pàrtiti dal male, e fa’ il bene, cerca la pace e persevera in essa)» (Sal. 33,15). L’illustrazione di tale programma di vita viene resa dal santo vescovo attraverso una metafora complessa, ispirata all’arte del giardinaggio, che doveva risultare ben comprensibile alla sua discepola. Su questa metafora varrà la pena tornare per un’analisi puntale che possa rendere ragione della genialità e dell’attualità del pensiero di Sant’Antonino.

